Fin dall’infanzia la passione di Teodoro Lorenzo è stato il pallone che egli bambino rincorreva nel cortile di casa. Passione che poi si è trasformata in amore per il gioco del calcio. Un amore che per un breve periodo è diventata anche una professione. Il suo ritiro dal mondo del calcio risale al 1988 ma egli sembra non aver mai tradito la sua grande passione né accantonato il suo amore. Per il pallone, per il calcio e per tutto ciò che sta intorno. Anche se nel libro afferma il contrario, dichiarandosi innamorato del “giocare al pallone” e non del “gioco del calcio”.
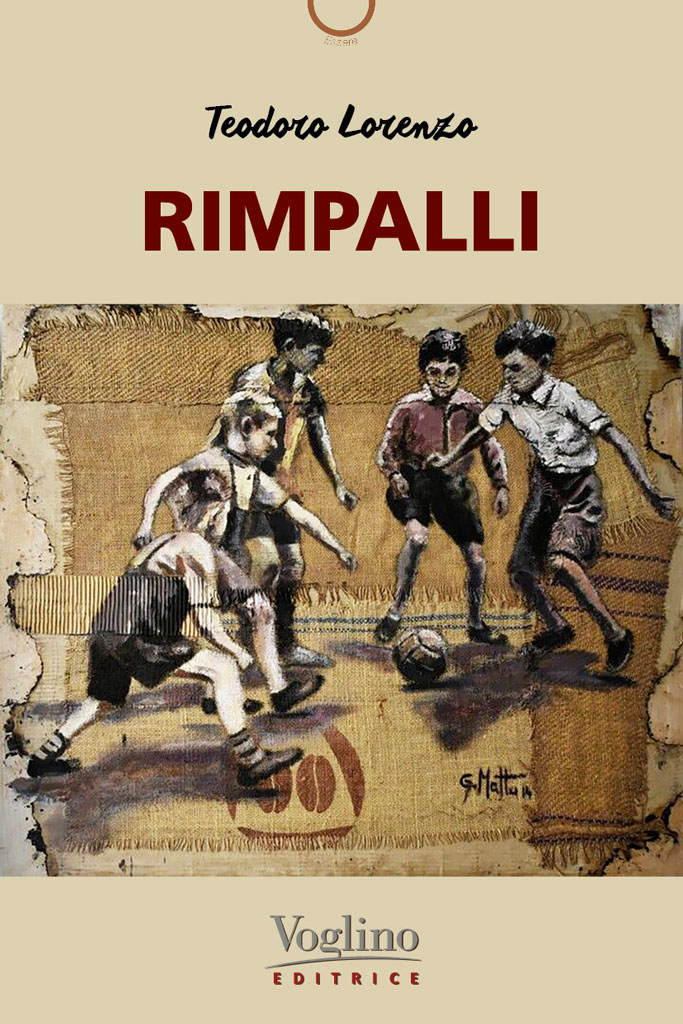
Come sottolineava il sociologo tedesco Kurt Weiss, nella percezione del tempo dei tifosi il presente ha un ruolo marginale1. Il legame identitario che anima una comunità di tifosi li porta infatti a privilegiare il passato, esaltando le gesta che sono parte della memoria collettiva della fandom2.
Anche l’autore sembra mantenere questo mood laddove ricorda, per quasi l’intero libro, i tempi andati.
Il libro si apre al lettore con un adagio che è la sintesi perfetta dell’intero libro: Nel corso del tempo i paesaggi cambiano; di quel che era restano soltanto cartoline ricordo. Esattamente ciò che risulta essere il libro di Teodoro Lorenzo al letto: una cartolina del tempo andato.
La struttura del libro è un po’ particolare. L’autore imposta i capitoli come fossero pagine del suo diario, iniziando sempre con indicazioni spazio-temporali e descrizioni che introducono l’argomento. Di quello che dovrebbe essere l’argomento. Perché, durante la narrazione, egli si lascia spesso andare a divagazioni che toccano le più svariate argomentazioni e che lasciano, in alcuni momenti, il lettore sconcertato, incerto sulla reale e ben comprensione dello scritto. Del contenuto come anche del messaggio che l’autore voleva comunicare. A tratti, le divagazioni presenti nel testo sembrano più delle arringhe da tribunale che narrazioni di parti biografiche.
In alcuni tra i più recenti scritti di Gianni Celati (Avventure in Africa, Cinema naturale, Fata morgana), la scrittura seguiva in modo singolare e autonomo il carattere, la fisionomia dello spazio rappresentato, e si faceva pertanto il più possibile senza ondulazioni. Ed era su quella piattezza che prendevano corpo quelle apparenze disperse negli spazi vuoti che il narratore cercava di ricucire: apparenze che cambiano a ogni apertura d’occhi, disorientamenti infiniti che richiedono sempre nuovi racconti, sospesi tra il fascino di un meraviglioso quotidiano da riscoprire tramite dettagli a prima vista insignificanti e terra desolata ostile e inappartenente come un pianeta lontano3. Teodoro Lorenzo sembra inseguire lo stesso ideale di scrittura.
Nel corso dei secoli la letteratura che ha ruotato intorno al tema dello sport e che a esso si è ispirata o come fonte di poesia o per ricavarne indicazioni morali si è trasformata, non sempre seguendo modelli uniformi. Essa ha piuttosto seguito i cambiamenti che hanno coinvolto non solo le varie attività atletiche ma anche i sistemi e i modi della comunicazione, secondando le mode e le culture delle epoche e delle civiltà diverse. Nella tradizione italiana, una testimonianza esemplare agli inizi dell’Ottocento ha impegnato uno dei giganti della nostra poesia: Giacomo Leopardi. Sul rapporto tra vigore del corpo e forza dell’animo lo Zibaldone è ricco di annotazioni. Nel mondo antico c’era una corrispondenza diretta tra possanza corporea e possanza spirituale, immaginativa, eroica, la quale è stata via via cancellata col progresso della ragione e con l’indebolimento dei corpi, disabituati a coltivare il vigore e l’agonismo4.
L’autore compie un’accurata critica del gioco del calcio oggi che, a suo dire, è diventato un altro sport. Una sorta di rugby giocato con i piedi. Manifesta apertamente la sua ostilità verso l’idea che il calcio sia un gioco collettivo a discapito del talento individuale. Per vincere, nella sua ottica, una squadra ha bisogno di giocatori forti, necessita di campioni. Non è il collettivo o la tattica a far vincere le partite: sono i giocatori.
Nella fisicità naturale del corpo umano i piedi, destinati all’equilibrio e al movimento, sono governati da una quantità di neuroni minore a quella degli apparati prensili e dell’articolazione. Ciò ha un’importante conseguenza: è difficile riuscire a padroneggiare un oggetto con un organo così sfavorito. Eppure è proprio la capacità di utilizzare i piedi per costruire la trama ripetuta delle azioni di gioco che viene esibita, con maggiore o minore destrezza, ogni volta che due squadre di calciatori si affrontano su un campo di calcio, sia esso un grande stadio che raccoglie migliaia di spettatori o un anonimo campetto di periferia. Il calcio non è un gioco naturale, ma, al contrario, un gioco tecnico difficile ed è proprio questa caratteristica che gli conferisce il fascino dell’imprevedibilità, spesso accompagnata dalla bellezza estetica con cui si manifesta.
Nonostante le variazioni locali e nazionali, gli antecedenti popolari del calcio moderno – sia in Francia sia in Inghilterra (soule e hurling over country) – avevano in comune almeno una caratteristica: erano tutte lotte fatte per gioco, ma con una tolleranza consuetudinaria per il livello di violenza fisica notevolmente superiore a quella consentita di norma nel calcio moderno.
In Italia, qualche secolo più tardi, il gioco del calcio raggiunge il suo momento di massimo fulgore a Firenze, sotto la signoria dei Medici. Gli incontri di calcio fiorentino si disputavano soprattutto in occasione di matrimoni principeschi e visite illustri avendo per teatro la piazza di Santa Croce o Santa Maria Novella, quando non venivano giocati in un grande prato, posto subito fuori le mura della città. Inizialmente riservato esclusivamente ai nobili, in seguito vi prendevano parte i giovani di tutte le contrade cittadine ed era un’attività nella quale tutti si sentivano coinvolti. Non vi era una separazione chiaramente definita tra il ruolo dei giocatori e quello degli spettatori. Ciò si riscontra a partire dall’epoca rinascimentale.
Se è storicamente vero che le regole del calcio sono nate nelle Public Schools inglesi, la diffusione di questo gioco come fenomeno sociale su scala internazionale ha seguito percorsi differenti a seconda delle nazioni in cui, nel corso del primo Novecento, esso ha messo profonde radici. Un processo che ha portato il calcio a divenire, in un arco di tempo abbastanza breve, the people’s game. Un gioco di tutti sia perché praticato, a livello professionistico e amatoriale, da giocatori di ogni classe sociale, sia perché il pubblico che assisteva alle partite era in genere socialmente molto composito.
Il calcio, inteso come attività sportiva di tipo agonistico praticata da un gran numero di giovani e meno giovani, è un aspetto tutto sommato secondario del calcio moderno, che è essenzialmente “calcio spettacolo”, una forma composita di attività agonistica e intrattenimento ludico nella quale il pubblico non è formato esclusivamente da semplici spettatori che assistono a una competizione/rappresentazione. Oggi il pubblico è divenuto esso stesso parte integrante di un evento sportivo, che manifesta la propria presenza partecipata con esibizioni scenografiche di vario tipo5.
Per quanto concerne i giocatori, se è vero che nelle gerarchie sociali alcuni si collocano ai gradini più alti della scala di ricchezza e popolarità, il loro prestigio e il loro potere sociale restano nel complesso modesti. Essi appartengono a quella che Alberoni ha definito, parlando del divismo, “l’élite senza potere”6.
In alcuni passaggi del libro anche l’autore sembra sentirsi una “élite senza potere”, soprattutto laddove ritiene che alle sue idee e opinioni non venga dato il giusto risalto e critica, e narra degli immeritati, a suo dire, avanzamenti di carriera di altri giocatori o allenatori. E la sua sembra diventare a tutti gli affetti una “voce senza potere”.
Sicuramente uno dei motivi che può averlo spinto a scrivere il libro è proprio la divulgazione del suo pensiero e delle sue personali opinioni.
L’autore dedica il libro a: Comandante Mark, Pietro Anastasi, Primo levi e se stesso.
Si tratta di una dedica quantomeno singolare, diretta a persone in vita e non, reali e no.
Il Comandante Mark è un personaggio immaginario, protagonista dell’omonima serie a fumetti western ideata nel 1966 dal gruppo di autori noto come EsseGesse (Pietro Sartoris, Dario Guzzon e Giovanni Sinchetto). Rimasto orfano e cresciuto in un villaggio pellerossa, Mark aderirà alla causa dei patrioti americani contro le Giubbe Rosse e, intorno a lui, si crea un gruppo di coloni denominati i Lupi dell’Ontario. Le avventure raccontate sono tipiche delle produzioni western.
Il genere western è il frutto dell’immaginazione di scrittori pulp, illustratori, pittori, fumettisti, politici e intellettuali. Non corrisponde alla realtà storica. La fortuna del genere è dovuta anche alle contraddizioni e ambivalenze che si possono trovare al suo interno, le quali permettono al western di adattarsi alle esigenze dei vari momenti culturali senza venire mai meno a una certa coerenza a una certa coerenza stilistica – fatto che dimostra quanto il western sia un genere molto meno statico e formulaico di quanto certa critica abbia voluto riconoscere7.
Come per il genere western anche la narrazione intorno al gioco del calcio è lontana dalla realtà?
Se da un lato la trasformazione di un gioco popolare inglese polimorfo in Association Football o soccer ebbe il carattere di un lungo sviluppo in direzione di una maggiore regolazione e uniformità8, dall’altro il calcio, come fenomeno storico-sociale, si è intrecciato dicaronicamente in maniera dialettica con diversi e complessi aspetti; certamente con il processo di progressiva industrializzazione e di crescita economica, come pure la transizione demografica, con l’urbanizzazione e con la modernizzazione politica.
L’agilità, la vigoria e le plastiche figure dei calciatori se richiamano, già nell’età giolittiana, l’attenzione di molti pittori – da Boccioni a Campigli a Montanari e, più tardi, Carrà sino a Guttuso e Schifano, tra gli altri – diventano pure argomento di racconti e narrazioni entusiastiche per il dinamismo del gioco e per quei gol talvolta inaspettati che gonfiano la rete.
Dall’entusiasmo al fanatismo il passo fu breve per Marinetti e i suoi accoliti futuristi. Lo sport era per loro un credo, un mito, ne facevano anch’essi una Musa ispiratrice9. Certamente il dannunzianesimo e il futurismo rispondevano ideologicamente al disegno fascista di mutazione antropologica della gioventù italiana.
L’interesse verso il gioco del calcio è proseguito anche nel secondo dopoguerra. Iperbole, alliterazioni, figure retoriche e metafore dal giornalismo sportivo trasmigrano nelle pagine della letteratura, ma anche nelle riflessioni filosofiche10 e psicoanalitiche11, configurando una riflessione culturale e un ampio dibattito non solo sul gioco ma anche sugli aspetti tecnici del calcio. Gli scrittori associano il gioco del calcio con un flash rivolto alle spalle: alla propria infanzia e alla propria adolescenza.
Il tema calcistico si dipana in molti articoli di Pasolini per quotidiani e periodici. Con sicura consapevolezza, egli afferma: Non sono né Roland Barthes né Greimas, ma da dilettante, se volessi, potrei scrivere un saggio sulla ‘lingua del calcio’12. Dunque il calcio è, tra le diverse tipologie, una lingua, ossia un sistema di segni, così come sistemi di segni non verbali sono propri della pittura, del cinema e della moda.
Una ragione per cui il calcio è considerato il “re” dei giochi potrebbe essere che, per praticarlo, lo si può fare con chiunque, in qualunque modo e ovunque. Si caratterizza, ieri come oggi, per il collettivo, la squadra, la cui organizzazione di gioco si può considerare un paradigma che aiuta a capire concretamente le implicazioni filosofiche a esso sottese. Se la squadra è la totalità, i giocatori sono le parti.
Riprendendo la definizione di Stato di Hegel, Matassi sovrappone i due concetti: Lo Stato rispetto alle sue componenti è il primo principio perché la famiglia e la società civile (le parti) realizzano il proprio fine solo se si commisurano allo Stato (la totalità)13.
Il gioco del calcio che, in questo senso, assume, o dovrebbe assumere, una forte valenza formativa nei giovani: educarli al rispetto delle regole, alla socializzazione, all’amicizia, al senso di appartenenza e alla sensibilizzazione interculturale.
Ma questo sport va in questa direzione, o contravviene ai principi etico-formativi appena accennati?14
Il presente sembra carico di dubbi, interrogativi e di premesse in parte negative; i principi etici fanno e faranno sempre i conti con il sistema di interessi economici delle oligarchie finanziarie; le squadre di calcio costituiscono un volano pubblicitario strategico proprio per la loro importanza mediatica. Appartiene ormai al passato il mecenatismo calcistico, quando i soci ne facevano una questione di prestigio sociale, oggi tutti parlano di soldi. Ma non si tratta nemmeno più di soldi, bensì di qualcosa di virtuale, che somiglia alle vendita all’asta di Sotheby’s, l’impressione è che le cose non abbiano più prezzo. Siamo entrati nel mondo della magia15.
L’autore sembra giungere alle medesime conclusioni e alle stesse critiche, giudicando severamente il calcio e il sistema in generale da cui si discosta e dissocia affermando di preferire di gran lunga il “gioco del pallone” a quello del “calcio” proprio per la sua estraneità a giochi di potere e interesse. Rievoca la spensieratezza del praticare questo sport in gioventù e in libertà, in un tempo che fu e che fa diventare il libro intero una “cartolina ricordo” del suo personale paesaggio cambiato.
Il libro
Teodoro Lorenzo, Rimpalli, Voglino Editrice, 2025.
1K. Weis, Tifosi di calcio nella Repubblica Federale Tedesca: violenze e provvedimenti, in A. Roversi (a cura di), Calcio e violenza in Europa, Inghilterra, Germania, Italia, Olanda, Belgio e Danimarca, Il Mulino, 1990.
2J. Bassi e E. Belloni, Più che un club. Tifoserie e identità storiche, in Diacronie. Studi di Storia contemporanea, n. 42, 2 | 2020.
3G. Almansi, Il letamaio di Babele, in Idem, La ragion comica, Feltrinelli, 1986.
4N. Soglia, Letteratura sportiva come genere? A un vincitore nel pallone, il rischio per vincere la noia, in Sinestesieonline – Supplemento della Rivista «Sinestesie», a. XI, n. 36, 2022.
5A. Cavalli, A. Roversi, Calcio: un fenomeno non solo sportivo, in Enciclopedia dello Sport, Treccani, 2002.
6F. Alberoni, L’élite senza potere, Vita e Pensiero, 1962.
7E. Bordin, L’invenzione del west(ern). Fortuna di un genere nella cultura del Novecento, in Iperstoria – Testi Letterature Linguaggi, 12 novembre 2012.
8N. Elias, La genesi dello sport come problema sociologico, in N. Elias Eric Dunning, Sport e aggressività, Il Mulino, 1989.
9S. Giuntini, Calcio e letteratura in Italia (1892-2015), Biblion, 2017.
10Si vedano: B. Welte, Filosofia del calcio, Morcelliana, 2021; S. Critchley, A cosa pensiamo quando pensiamo al calcio, Einaudi, 2021; E. Matassi, La filosofia del calcio. In dialogo con Lucrezia Ercoli, Mimesis, 2023.
11U. Amato, La psicoanalisi del calcio. In dialogo con Sabrina Semprini, Tabula Fati, 2015.
12P.P. Pasolini, Il calcio «è» un linguaggio con i suoi poeti e prosatori, su Il Giorno, 3 gennaio 1971.
13E. Matassi, La filosofia del calcio. In dialogo con Lucrezia Ercoli, Mimesis, 2013.
14F. Bacchetti, Tra le pagine di scrittori e giornalisti-scrittori: una svolta stilistica, linguistica e interpretativa del calcio, in Studi sulla formazione, 26, 2023.
15V. Dimitrijević, La vita è un pallone rotondo, Adelphi, 2000.
Articolo pubblicato su Satisfiction.eu
© 2025, Irma Loredana Galgano. Ai sensi della legge 633/41 è vietata la riproduzione totale e/o parziale dei testi contenuti in questo sito salvo ne vengano espressamente indicate la fonte irmaloredanagalgano.it) e l’autrice (Irma Loredana Galgano).
