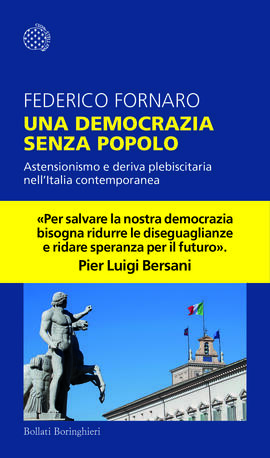La democrazia non gode di buona salute. Sono molti i fattori che ne stanno erodendo le fondamenta e che mettono in serio pericolo la tenuta delle istituzioni. Non si tratta di una questione tecnica, lontana dal sentire della gente: è un problema che tocca da vicino la nostra vita quotidiana, la nostra società, minando il futuro di ciascuno di noi. Fornaro racconta dei quattro silenziosi “tarli del legno” che stanno scavando nel tessuto vivo delle democrazie: le diseguaglianze sempre più marcate (economiche e non solo), la perdita di memoria storica, l’uso spregiudicato delle fake news con il conseguente avvelenamento delle fonti della conoscenza e la mancata fiducia nel futuro.
L’autore invoca una difesa quotidiana e a oltranza della democrazia, per la difesa di quanto faticosamente raggiunto dopo il fascismo e per scongiurare il rischio di scivolamento verso forme di democrazia illiberale.
È importante partire dall’analisi del concetto stesso di democrazia e dal significato che le viene comunemente attribuito. Se la si vuol considerare come il governo del popolo allora non si può parlare di crisi perché ciò è sempre stato e sempre sarà un ideale irrealizzabile. Piuttosto intenderla come una formula di giustizia: un criterio per distribuire un bene, il potere politico, secondo il voto degli elettori1.
Uno dei punti su cui l’autore maggiormente si sofferma è l’astensionismo elettorale, da lui ritenuto, seguendo la scia dei pensatori europei, una grande criticità che comporta un elevato rischio di delegittimazione della democrazia.
Dei quattro “tarli” da lui indicati il più insidioso è la perdita di memoria storica, lesiva non solo per il presente, che diviene incomprensibile, ma soprattutto per il futuro. L’oblio della memoria che preannuncia l’eclissi del futuro, una contraddizione che ci induce a vivere in un eterno presente. Non si riesce più a comprendere la complessità della contemporaneità e la necessità di avere un approccio critico.
I quattro silenziosi “tarli del legno” che agiscono indisturbati da anni ormai producono, per Fornaro, una polvere bianca rappresentata dagli astensionisti. In Italia come in tutta Europa questi appartengono, per l’autore, in maggioranza al ceto medio-basso, con un basso livello di istruzione, e con una percezione dello Stato distante da interessi e problemi. Si sentono esclusi e demotivati. Marginali, come le aree dove vivono. Più alto infatti risulterebbe l’astensionismo nelle periferie rispetto al centro. Nelle aree montane e rurali rispetto al capoluogo della provincia. Un ritorno alla marginalità sociale ed economica che è evoluta in un risentimento che vede nell’astensionismo una forma di protesta.
Il non voto sfida la democrazia nella misura in cui costituisce una critica, nemmeno tanto velata, ai suoi attori e alle sue procedure. Astenendosi, gli elettori intendono ripagare i governanti con la loro stessa moneta, le cui due facce sono l’indifferenza e l’ostilità. Gli astensionisti sono un popolo più nomade che stanziale, la cui composizione è alquanto mutevole. I fattori che vanno a incidere, di volta in volta, sull’astensionismo sono molteplici e svariati ed è proprio il peculiare mix di questi fattori che spiega, per ogni elezione, quante e quali persone si recheranno alle urne. Sempre più spesso, però, questo mix produce una scarsa affluenza. Il problema che ne deriva è che se la soglia della partecipazione si abbassa più di un tanto, l’astensionismo sembra destinato ad avvitarsi su se stesso. Se a votare è una minoranza di elettori, è evidente che anche il senso di doverosità del voto, vero argine all’astensione, prima o poi verrà meno2.
La tesi espressa dall’autore è che il rischio reale non è un ritorno al passato, alle dittature del secolo scorso, bensì un andare incontro alle cosiddette “democrature”, forme di governo nelle quali non viene messo in discussione l’impianto generale della democrazia ma solo l’uso che delle sue strutture se ne fa. Una democrazia illiberale nella quale chi vince ritiene di avere pieno accesso e possesso per l’intera durata del mandato senza preoccuparsi minimamente degli equilibri politici e di potere.
La democrazia di derivazione liberale, o democrazia costituzionale, è una variante della classe “democrazia” o “Stato democratico” nella sua evoluzione storica. Si tratta del contemperamento tra diverse componenti – liberale, democratica e sociale – riflesse in una specifica cornice costituzionale che ha avuto un’espansione continua a partire dalla fine della seconda guerra mondiale. Tale evoluzione ha prodotto un risultato che ha consentito per oltre 70 anni alle democrazie occidentale di costituire un modello da esportare in altre aree d’Europa e del globo al termine dei regimi autoritari o socialisti e che è riflesso nei requisiti della condizionalità democratica europea. Tuttavia, la divaricazione tra profilo liberale e profilo democratico torna all’attenzione della dottrina nel momento in cui la componente liberale (in termini di divisione dei poteri, contrappesi contro-maggioritari e libertà fondamentali) viene confutata nelle versioni demagogiche e populiste o iper-maggioritarie della democrazia3. Già Sartori chiariva bene la diversa origine dell’ideale liberale e di quello democratico che, nella seconda metà del XIX secolo, si sarebbero fusi e confusi4. Gli equivoci deriverebbero dal fatto che, per indicare la democrazia, a volte si usa il termine “liberal-democrazia” (riversando nella democrazia tutti gli attributi del liberalismo) e altre solo “democrazia” (divaricando i due contenuti). Nel primo caso si lega il concetto di democrazia a quello di “governo costituzionale”5.
La tendenza emergente è che alcune “democrazie liberali” stiano diventando sempre meno democratiche e sempre meno liberali, proprio mentre alcuni regimi autoritari e semi-autoritari stiano diventando ancora più autoritari. La normalizzazione del fenomeno, dovuta anche a un aumento del sentimento di disaffezione verso le istituzioni democratiche, di un crescente sostegno a interpretazioni autoritarie di governo e la sua espansione in diverse aree del mondo, sta portando alcuni sistemi costituzionali a mutare in direzione di forme light di democrazia, che mettono da parte la tutela e la protezione dei diritti e delle libertà delle persone. In Europa, per esempio, insieme all’Ungheria è emblematico anche il caso della Polonia, che ha subito dei profondi cambiamenti da quando è stata ammessa nell’UE. Al momento dell’ammissione, aveva garantito il rispetto dei principi della “democrazia liberale”, mentre ora si assiste a una sottomissione progressiva del potere giudiziario all’organo esecutivo6.
Per Fornano questi nuovi nemici della democrazia sono più subdoli di quelli del secolo scorso perché non agiscono con attacchi diretti, per esempio alla costituzione, ma operano indirettamente, sminuendo l’antifascismo o ridimensionando gli attacchi ripetuti alla libertà di stampa.
Per l’autore è tempo di agire e di essere risoluti come i silenziosi quattro “tarli del legno” affinché si torni ad avere fiducia nella politica e nelle istituzioni democratiche e non si cada nella trappola della demagogia.
La politica e le istituzioni democratiche hanno quindi il precipuo dovere di porsi nella condizione di meritare la piena fiducia dell’elettorato e dei cittadini tutti. Coerenza, credibilità e affidabilità potrebbero risultare essere la migliore arma contro la sfiducia e l’astensionismo. L’urlo silenzioso delle urne vuote è un boomerang che attacca il presente, intacca il futuro e cancella gli sforzi di un passato che mai andrebbe dimenticato.
Il libro
Federico Fornaro, Una democrazia senza popolo. Astensionismo e deriva plebiscitaria nell’Italia contemporanea, Bollati Boringhieri, Torino, 2025.
1M. Barberis, L’incanto del mondo. Un’introduzione al pluralismo, Meltemi, Sesto San Giovanni (Milano), 2024.
2V. Mete, D. Tuorto, Gli astensionisti, in Il Mulino – Rivista di Cultura e di Politica, 3 giugno 2025.
3A. Di Gregorio, La degenerazione delle democrazie contemporanee e il pluralismo semantico dei termini “democrazia” e “costituzionalismo”, in Saggi-DPCE online, 2020/3.
4G. Sartori, Democrazia e definizioni (1957), Il Mulino, Bologna, 2025.
5A. Di Gregorio, op.cit.
6G. D’Ignazio, Le democrazie illiberali in prospettiva comparata: verso una nuova forma di Stato? Alcune considerazioni introduttive, in Saggi-DPCE online, 2020/3.
Articolo pubblicato su Satisfiction.eu
© 2025, Irma Loredana Galgano. Ai sensi della legge 633/41 è vietata la riproduzione totale e/o parziale dei testi contenuti in questo sito salvo ne vengano espressamente indicate la fonte irmaloredanagalgano.it) e l’autrice (Irma Loredana Galgano).