Un tempo fonte di imbarazzo, vergogna, senso di inferiorità, l’ignoranza è oggi un prodotto di straordinario successo, spesso sbandierato con orgoglio. E l’Italia è uno dei migliori luoghi al mondo per la sua ideazione, produzione, commercializzazione e consumo.
Questa, in sostanza, la tesi del libro di Paolo Guenzi. Un testo che indaga a fondo il fenomeno che ormai sembra dilagare nella vita reale come anche in quella virtuale.
Ma come si è arrivati a tutto ciò? Si chiede l’autore.
Anche attraverso il marketing dell’ignoranza, ovvero il sofisticato processo di creazione e diffusione dell’ignoranza quale valore e pratica quotidiana nella vita della società. È la risposta che si dà e che argomenta ampiamente nel libro.
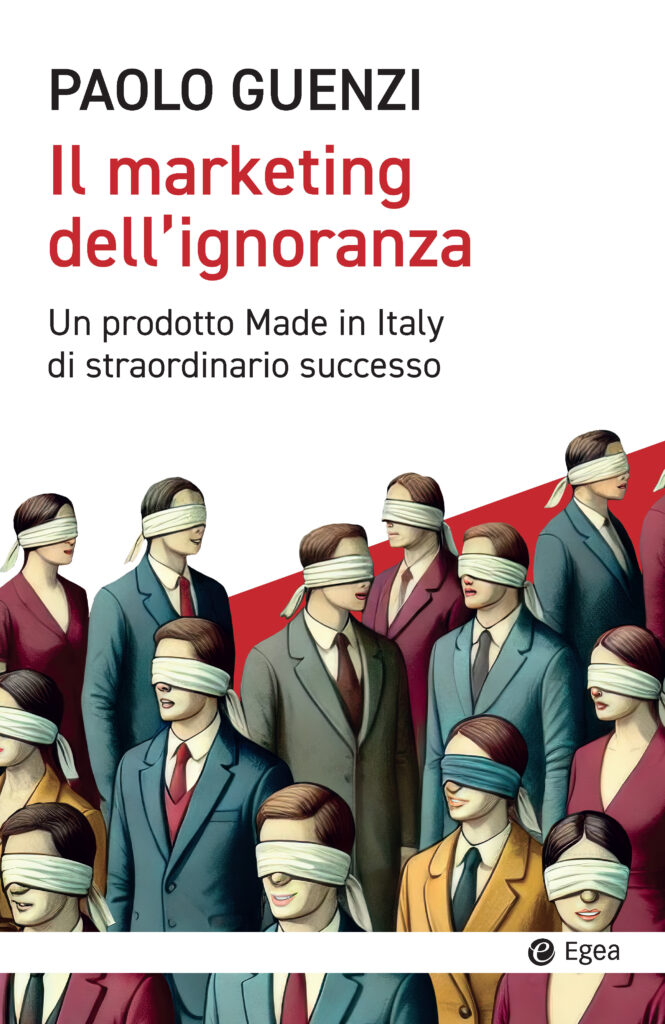
Logiche e strumenti di marketing pensati per migliorare i rapporti fra le imprese e i loro clienti possono diventare nocivi per la comunità se diffusi su larga scala senza responsabilità e senso critico, in modo malevolo, spregiudicato e opportunistico. Si tratta di un meccanismo subdolo e sublimale, un’asticella invisibile che si alza progressivamente, un virus che inesorabile divora la coscienza della collettività contaminando ideali, pensieri, emozioni e comportamenti.
È inutile negarlo, sottolinea Guenzi nel libro, l’ignoranza da noi piace, e molto. E fa fare anche un sacco di soldi.
Un posto d’onore, in questo processo di galoppante affermazione del marketing dell’ignoranza, l’autore lo riserva ai politici e ai pubblici amministratori, nonché al sistema dei mezzi di informazione.
Per la maggior parte dei filosofi e dei principali pensatori della storia, l’ignoranza è un fenomeno negativo. La cultura, invece, ha una connotazione positiva. Per Spinoza, chi aumenta il proprio sapere accresce anche la gioia di vivere. Conoscenza e cultura sono precondizioni per essere felici. Ma allora perché l’ignoranza è così diffusa e addirittura valorizzata?
L’autore ricorda l’antico detto dell’Ecclesiaste: «Qui auget scientiam, auget et dolorem» (Chi accresce la propria sapienza, aumenta anche le proprie sofferenze).
È una visione condivisa da Schopenhauer, secondo il quale «nella stessa misura in cui la conoscenza perviene alla chiarezza, e la conoscenza si eleva, cresce anche il tormento, che raggiunge perciò il suo massimo grado nell’uomo, tanto più, quanto più l’uomo distintamente conosce ed è più intelligente. La persona in cui vive il genio, soffre più di tutti».
L’ignoranza costituisce un potente antidoto a molte forme di sofferenza, un formidabile anestetico a molte delle difficoltà, dei dubbi, dei tormenti che la vita inevitabilmente propone. All’estremo, l’ignoranza porta a una insensibilità che riduce o elimina la vulnerabilità. Non è solo una condizione, ma in molti casi anche una filosofia esistenziale, una scelta quotidiana (più o meno consapevole), un modo di essere, di intendere la propria vita e la relazione con il mondo e, in particolare, con le persone intorno a noi. Al riguardo, sottolinea Guenzi, in Italia la situazione è decisamente grave: secondo il Rapporto PIACC del 2024, nel nostro Paese il 35% degli adulti è in una condizione di analfabetismo funzionale, cioè sa leggere ma fatica a comprendere il senso anche solo di frasi semplici, e non riesce a eseguire calcoli matematici elementari. Questi dati ci collocano agli ultimi posti fra i Paesi OCSE, industrializzati.
Lo studio di Paolo Guenzi dimostra quanto queste persone, in tali condizioni, difficilmente possono gestire le complessità della vita contemporanea, orientarsi nella massa delle informazioni e contribuire al raggiungimento di decisioni e politiche più consapevoli, il che rappresenta una preoccupazione crescente per le democrazie moderne.
Nella maggior parte dei casi le compagnie di comunicazione delle strategie di marketing di maggiore successo sono accomunate dalla volontà e capacità di costruire un mondo idealizzato e rasserenante in cui i problemi, le preoccupazioni, le fatiche, le difficoltà e le fisiologiche brutture della vita sono magicamente assenti. Di per sé, trasmettere un modello di esistenza leggero, sereno e allegro non è un crimine, tuttavia, come per altri ingredienti del marketing dell’ignoranza, l’impatto sulla collettività della sistematica disseminazione a reti unificate di questa visione idealizzata e irrealistica del mondo ha conseguenze profonde sul sistema di valori e sullo stile di vita di un’intera società. Per Guenzi, l’interiorizzazione collettiva di uno pseudomondo artificiale in cui quasi tutti sorridono e si godono la vita rende inconciliabili con la propria esistenza altri concetti connaturati agli esseri umani come fatica, sofferenza, dolore, impegno.
In una società così profondamente e pervasivamente dominata dall’apparire e dalla sovra-comunicazione, qualsiasi dato, abilità, conquista, risultato non conta in sé, ma vale solo nella misura in cui viene mostrato ad altri. Non c’è gratificazione senza condivisione.
Ed ecco allora che la vita immaginaria delle campagne di comunicazione diventa la vita immaginata degli utenti dei social network.
Anche la smart-economy, per certi versi, è un sintomo del marketing dell’ignoranza nella misura in cui si producono prodotti sempre più intelligenti per consumatori sempre più stupidi. Ritiene infatti Guenzi che, a livello sistemico, all’aumentare dell’intelligenza dei prodotti corrisponda necessariamente, o comunque con un alto grado di probabilità, una generale riduzione dell’intelligenza degli esseri umani che li acquistano, utilizzano e consumano. Lo sviluppo della conoscenza e dell’intelligenza in senso più lato deriva infatti in buona parte dall’apprendimento che scaturisce dagli errori.
Il marketing dell’ignoranza è un racconto in chiave minuta di quanto è sotto gli occhi di tutti. L’autore, contrariamente a quanto accade per le sue altre pubblicazioni, ha accantonato lo stile accademico e ricercato, ha ridotto al minimo fonti, citazioni e dati. Limitandosi a riportare la cruda a amara realtà dei fatti. L’ovvietà di ciò che l’autore scrive – intendendo con ovvietà il fatto che quanto egli racconta sia palesemente oggettivo e reale – dovrebbe essere di per sé un deterrente a proseguire lungo questa via eppure sembra che questo delirio del marketing dell’ignoranza, con tutti gli annessi e connessi, volga invece in direzione opposta, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone, e colpisca trasversalmente per fasce di età e reddito. Gocce di un vero e proprio “lento tsunami” che si abbatte ogni giorno su cultura, formazione e intelletto.
Il libro
Paolo Guenzi, Il marketing dell’ignoranza. Un prodotto Made in Italy di straordinario successo, Milano, Egea, 2025.
Disclosure: Per l’immagine in evidenza, credits www.pixabay.com
Articolo pubblicato su Satisfiction.eu
© 2025, Irma Loredana Galgano. Ai sensi della legge 633/41 è vietata la riproduzione totale e/o parziale dei testi contenuti in questo sito salvo ne vengano espressamente indicate la fonte irmaloredanagalgano.it) e l’autrice (Irma Loredana Galgano).



