Tag
GiovanniCecini, Lincredibilestoriadellasecondaguerramondiale, Luomochefeceperderelaguerraainazisti, MaledettaGuerra, NewtonCompton, recensione, RobertHutton, saggio
Analisi dei testi L’incredibile storia della seconda guerra mondiale di Giovanni Cecini e L’uomo che fece perdere la guerra ai nazisti di Robert Hutton (Newton Compton Editori, Roma, 2019)

Una guerra, per quanto nefasta e criticabile, ha per sua natura una fine, connaturata nell’esaurimento delle possibilità di vittoria.
Cosa caratterizza allora la seconda guerra mondiale?
La Germania e in parte anche il Giappone proseguirono il conflitto al mero scopo di distruggere l’umanità insieme a loro. Ecco spiegato, per Cecini, il motivo per cui questo fu un qualcosa al di sopra del conflitto militare, essendo un momento esistenziale della storia dell’umanità.
Il ricorso all’ideologia esasperata, più che la violenza in se stessa, fu la vera discriminante nel ritenere il Tripartito condannabile dall’intera umanità, ancor prima della sconfitta in campo.
I “genocidi industriali” del Reich e l’apocalisse infernale delle due bombe atomiche sul Giappone hanno messo negli anni a seguire in profonda crisi morale il senso etico dell’esistenza dell’uomo.
Si parla spesso del dramma provocato dai bombardamenti a tappeto e si ignorano invece i “frequentissimi casi di cannibalismo tra la popolazione civile” come tra le stesse truppe combattenti. Si citano, anche a sproposito, le cosiddette “marocchinate” ma si tende a minimizzare come lo “stupro fosse un autentico mezzo bellico in tutti gli eserciti, nel Tripartito come tra gli Alleati”.
Esempi che da soli basterebbero a rendere l’idea di quanto devastante sia stato il secondo conflitto mondiale. Eppure, come accaduto e accade per ogni grande evento storico, si sceglie a tavolino cosa tramandare. Tutto il resto deve finire nel dimenticatoio. E così sarebbe se non ci fossero studiosi come Cecini.
Tutti i conflitti bellici in realtà, siano essi mondiali e non, andrebbero analizzati come ha fatto Giovanni Cecini e magari anche in questo modo somministrati agli studenti, soprattutto quelli dei gradi superiori. Sicuramente risulterebbe loro più utile, interessante e stimolante studiarli. Piuttosto che nella classica versione cronologica, inaridita da nomi, luoghi e date.
Potrebbe risultare essere un modo migliore per comprendere gli accadimenti, le motivazioni, gli errori e le conseguenze. Diventando anche uno stimolo per moniti futuri.

L’incredibile storia della seconda guerra mondiale di Giovanni Cecini è un libro metalogico, all’interno del quale il conflitto bellico non è semplicemente raccontato, bensì prima scomposto per essere poi ricomposto, sebbene su piani di analisi differenti. L’autore utilizza la metafora dello specchio frantumato, avendo egli avuto cura di raccontare quel che si vedeva nei singoli frammenti, diversi tra loro per forma e dimensione. Un libro costruito quindi sulla riflessione che invita per certo a riconsiderare il solido mainstream venutosi a creare, guardandosi bene però dall’incitare allo scandalo o alla scoperta sensazionale. Nulla di tutto questo si troverà all’interno del testo. Quella di Cecini è un’analisi accurata, ponderata e basata su dati e fatti concreti, reali. Un’analisi investigativa condotta con grande competenza e professionalità.
La documentazione e l’analisi storica infatti non andrebbero mai trattate al pari del gossip o della cronaca nera. La volontà di diffondere un vero, o presunto tale, scoop non è mai di aiuto a chi vuol fare chiarezza.
Analizzare a fondo i fatti, le decisioni, le scelte e le costrizioni… scandagliare il tutto come fa un sonar tra i fondali marini, senza cadute scandalistiche o pregiudizi di sorta, aiuta senz’altro a meglio comprendere le ragioni di dette scelte, giuste o sbagliate che siano.
Studiare le congiunture del particolare momento storico di riferimento, raffrontarle con altre situazioni, analoghe oppure opposte, riflettere sui danni causati e le altre conseguenze… tutto ciò contribuisce in larga misura ad acquisire maggiore consapevolezza di passato e presente e dovrebbe essere anche di grande supporto per comporre al meglio il futuro.
Non sono per certo necessarie leggende metropolitane o falsità, le odierne fake news, per rendere avvincente o intrigante un conflitto bellico.
Lo storico deve voler comprendere, non accontentarsi di ricevere a scatola chiusa delle verità consolatorie e di comodo. Vale anche lo studioso e lo studente.
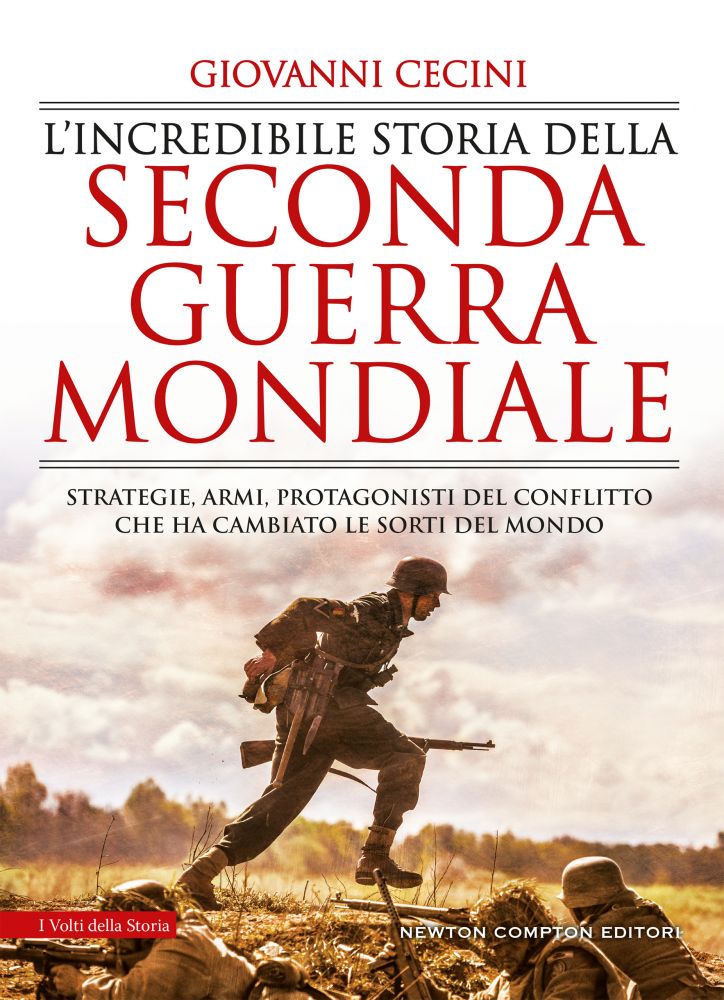
Ma qual è stato il senso più autentico della seconda guerra mondiale?
Cecini sottolinea più volte nel testo come non sia possibile dare una risposta univoca a questa domanda. Il conflitto è stato ed ha rappresentato tante cose, diverse e anche opposte tra loro.
Negli anni successivi al conflitto, e soprattutto di recente, molte volte si è messo in dubbio “il valore morale” degli alleati, perché spesso il loro ruolo è stato mitizzato e “portato su un piano diverso da quello meramente storico”.
Di sicuro c’è che, grazie proprio alla seconda guerra mondiale, l’America è diventata a tutti gli effetti la prima potenza economica a livello mondiale, mentre la Cina e l’Unione Sovietica hanno assoggettato milioni di liberi cittadini con la forza e la paura, imponendo loro il proprio credo politico.
Il Paese che invece ne è uscito vittorioso solo sulla carta sembrerebbe essere stato il Regno Unito. Partito agli inizi del Novecento come unica e indiscussa superpotenza mondiale, nel giro di quarant’anni si è visto scippare il titolo prima dall’America e poi dall’Unione Sovietica. Uno strappo mai completamente risanato.
Chi invece è riuscita a superare anche il crollo del vecchio impero coloniale è stata la Francia perché, come ricorda e sottolinea Cecini, l’Africa è quasi più francese oggi di ottant’anni fa.
Ad ogni modo, tutte le grandi potenze interessate al conflitto sono le stesse che oggi vanno a comporre il G8, con la sola aggiunta della Cina, paese che riveste un peso sempre maggiore nel contesto socioeconomico internazionale.
La grande eredità che ha lasciato la seconda guerra mondiale, per anni nei popoli di tutto il mondo, è stata la speranza di un mondo migliore. Ma, senza ombra di dubbio, e bene fa Cecini a ricordarlo nel suo libro, la divisione in blocchi contrapposti, il mancato giudizio verso tutti i criminali di guerra, nonché l’esasperazione della Guerra Fredda hanno di molto diluito i grandi e buoni proposito scaturiti al termine del conflitto.
Se ci si dimentica che molti dei problemi attuali non sono altro che conseguenze della seconda guerra mondiale, allora davvero si rischia non solo di “perdere un patrimonio di esperienze molto prezioso” ma anche e soprattutto di “rendere vane le morti di milioni di persone”.
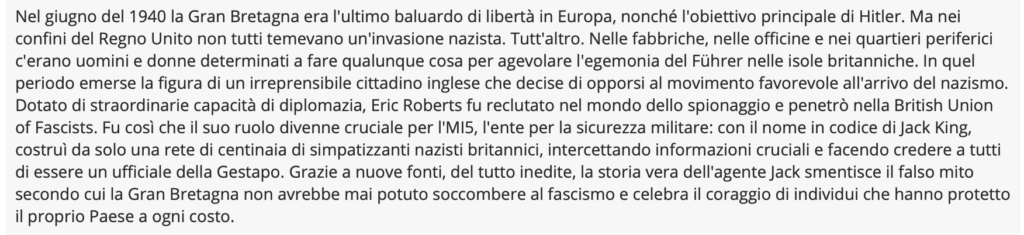
Commentando L’uomo che fece perdere la guerra ai nazisti di Robert Hutton, Tony Robinson ha affermato:
«In un’epoca in cui lo spettro dell’antisemitismo torna a fare paura, questo incredibile libro è indispensabile per ricordare che non siamo immuni alla minaccia del fascismo»
Il libro di Hutton nasce con lo scopo precipuo di voler raccontare una storia deliberatamente celata, come spesso accade, nella presunzione o illusione che non parlare di qualcosa di sgradevole aiuti a cancellarlo o, quantomeno, a fare in modo che rimanga nell’ombra e finisca quanto prima nel dimenticatoio anche per coloro che ne sono, in tutto o in parte, a conoscenza.
Ciò lo si fa anche per evitare di dare un’immagine di sé o del proprio Paese sbagliata, o comunque non corrispondente a quella che invece si vuole dare.
Hutton, al pari di quanto fatto da Cecini, ha narrato di un qualcosa che ha molto di incredibile, ma lo ha fatto con rigore e serietà, senza scoop sensazionalistici o allarmismi complottisti. Lo ha fatto semplicemente raccontando la verità, riportando date, dati, nomi e fatti concreti.
Si tratta di argomenti spinosi e questo è evidente, come lo è il fatto che a partire dal 2 settembre 1945 di tante cose si è preferito non parlare più. Troppo era accaduto. Bisognava solo mettere un punto fermo, voltare pagine e ricominciare. Ricostruire interi paesi manche anime ed esistenze.
Così facendo però non si è data la possibilità di analizzare molti aspetti ed eventi. Accadimenti e movimenti di pensiero che si è creduto di aver eliminato per sempre. Oggi, purtroppo, scopriamo che così non è stato. In tanti paesi europei certe idee hanno sempre continuato a bruciare, come fuoco sotto la cenere, magari anche in virtù del fatto che di ciò non se ne doveva parlare.
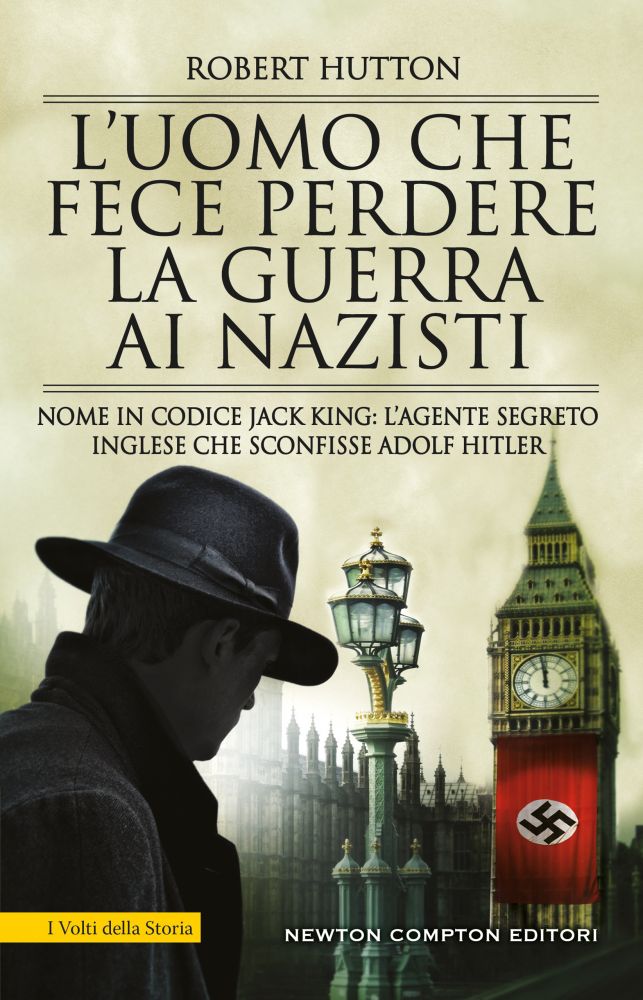
Il narrato del libro di Hutton è una storia vera.
Sin dal 1945 la Gran Bretagna “ha raccontato a se stessa una storia della guerra”. In questa narrazione, non solo il Paese si opponeva da solo alle forze militari del fascismo ma era anche straordinariamente resistente all’ideologia stessa. Mentre altre nazioni soccombevano a idee simili o collaboravano con gli invasori, la Gran Bretagna restava salda. Quella forza di carattere salvò non solo il Regno Unito ma l’Europa tutta.
Questa la versione narrata dagli inglesi agli inglesi, come al resto del mondo, e riportata da Hutton nel testo. Ma “l’MI5 conosceva una storia diversa”. Ed è di quella che racconta l’autore.
Verso la fine della guerra, i servizi segreti avevano identificato centinaia di uomini e donne britannici, in apparenza leali ma che bramavano una conquista da parte dei nazisti. Alcuni di loro si erano addirittura spinti oltre, rischiando finanche la vita per aiutare il Fuhrer. La gran parte delle testimonianze sono andate o sono state distrutte, eppure permangono le trascrizioni di oltre seicento conversazioni, avvenute tra il 1942 e il 1944, nelle quali si legge di come questi cittadini britannici discutono su come sia meglio muoversi per “tradire il proprio Paese con la Germania”.
È stato possibile, per Hutton, raccontare questa storia grazie alla decisione di rendere pubblica una selezione di dossier storici dell’MI5.
Solo così ha potuto vedere la luce L’uomo che fece perdere la guerra ai nazisti, che ricostruisce nel dettaglio l’operato dell’agente segreto inglese identificato con il nome in codice Jack King.
Un libro che è stata anche una grande sfida per l’autore. Nel tentativo continuo di voler descrivere l’intero quadro attraverso l’assemblaggio di un puzzle di cui non possiede tutti i pezzi. Alcuni ancora rimangono un mistero. La speranza, per Hutton, è che in futuro altri dossier vengano desecretati, anche se è consapevole che la scoperta di nuove informazioni potrebbe rivelare errori, naturalmente commessi in buona fede, nella ricostruzione da lui stesso fatta nel testo.
I libri di Giovanni Cecini e Robert Hutton hanno davvero un valore incredibile per la conoscenza e l’analisi di un periodo della recente storia che andrebbe sezionato tutto per essere ben compreso. Esattamente come ha fatto Cecini e, in un certo qual modo, lo stesso Hutton che ha puntato un riflettore su un punto preciso e poi ha zoomato quanto più gli è stato possibile fare.
L’incredibile storia della seconda guerra mondiale e L’uomo che fece perdere la guerra ai nazisti sono due lavori accurati, precisi, interessanti e assolutamente necessari.
Bibliografia di riferimento
Giovanni Cecini, L’incredibile storia della seconda guerra mondiale. Strategie, armi, protagonisti del conflitto che ha cambiato le sorti del mondo, Newton Compton Editori, Roma, settembre 2019.
Robert Hutton, L’uomo che fece perdere la guerra ai nazisti. Nome in codice Jack King: l’agente segreto inglese che sconfisse Adolf Hitler, Newton Compton, Roma, ottobre 2019.
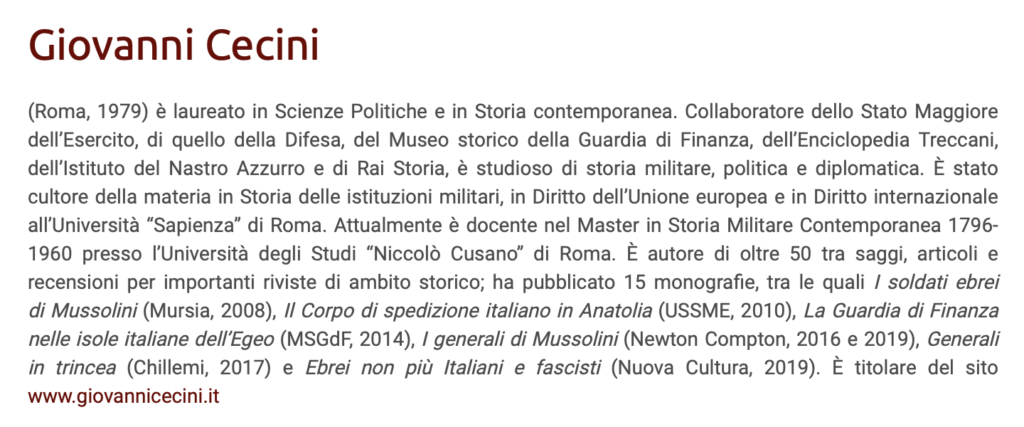
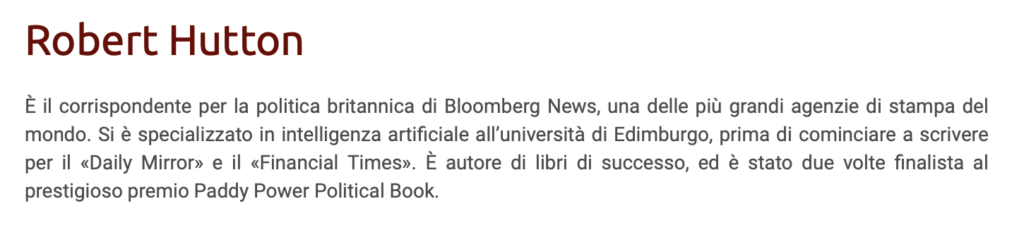
Articolo originale qui
Source: Si ringrazia l’Ufficio Stampa della Newton Compton Editori per la disponibilità e il materiale
LEGGI ANCHE
L’Italia nella Prima guerra mondiale, un’inutile strage. Intervista a Lorenzo Del Boca
© 2020, Irma Loredana Galgano. Ai sensi della legge 633/41 è vietata la riproduzione totale e/o parziale dei testi contenuti in questo sito salvo ne vengano espressamente indicate la fonte irmaloredanagalgano.it) e l’autrice (Irma Loredana Galgano).






